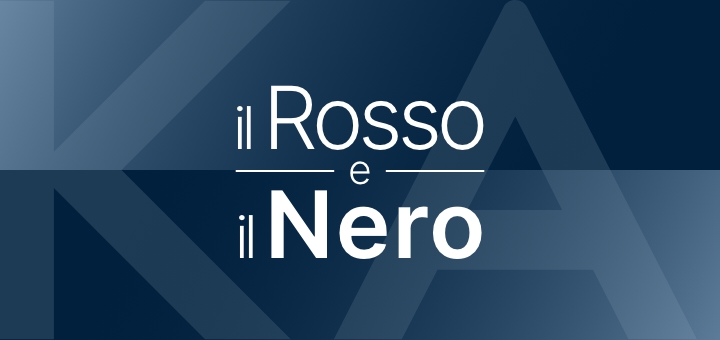
LA TRAPPOLA DI GIUSTINIANO
Bisanzio sta all’Europa come l’impero romano d’occidente sta all’America? Su questa ipotesi, l’influente trimestrale Internationale Politik propone, in un articolo a firma di Alexander Clarkson, il concetto di trappola di Giustiniano. La rivista è organo del German Council of Foreign Relations, un organismo modellato su Chatham House e sul Council on Foreign Relations, laboratori di establishment in cui si elaborano le linee guida strategiche cui si sono speso ispirate le politiche internazionali dei paesi occidentali.
Bisanzio sta all’Europa come l’impero romano d’occidente sta all’America? Su questa ipotesi, l’influente trimestrale Internationale Politik propone, in un articolo a firma di Alexander Clarkson, il concetto di trappola di Giustiniano. La rivista è organo del German Council of Foreign Relations, un organismo modellato su Chatham House e sul Council on Foreign Relations, laboratori di establishment in cui si elaborano le linee guida strategiche cui si sono speso ispirate le politiche internazionali dei paesi occidentali.
A differenza della trappola di Tucidide, un concetto che prende spunto dal conflitto tra l’egemone Sparta e l’emergente Atene e che ipotizza l’inevitabilità della guerra tra l’egemone America e l’emergente Cina, la trappola di Giustiniano riguarda l’ipotesi che l’Europa, come una nuova Bisanzio, raccolga l’eredità di un’America in piena decadenza che si ritira dal mondo e si avvia verso un declino irreversibile.
A differenza dei suoi predecessori, Giustiniano, che è imperatore dal 527 al 565, non si limita a difendere la parte orientale della Romània contro i suoi numerosi e agguerriti nemici, ma cerca di riconquistarne la parte occidentale. Italia, Spagna e Nord Africa ritornano effettivamente sotto il controllo imperiale, ma la riconquista, costosa ed effimera, non ripristina gli splendori di Roma ma, al contrario, dissangua e indebolisce strategicamente una Bisanzio sovraestesa. Meglio sarebbe stato se Bisanzio avesse cercato una convivenza con la Persia sasanide o l’emergente mondo romano-barbarico.
L’Europa, suggerisce l’articolo, farà bene a non cercare di fare dell’euro il continuatore del dollaro. Proporsi al mondo come erede diretta dell’impero americano e della sua egemonia globale finirà con l’indebolirla. Meglio, per l’Europa, accettare un mondo multipolare e inserirsi con autorevolezza nel confronto con Cina, India, Brasile e con tutte le potenze che emergeranno nel mondo post-americano.
Fin qui l’articolo, che è molto breve e non analizza le implicazioni economiche e finanziarie di un allargamento delle funzioni di moneta di riserva da parte dell’euro. Provando a fare qualche ipotesi, il ritorno a casa dell’esorbitante privilegio che fu della sterlina e poi del dollaro indurrebbe l’Europa ad accelerare sulla strada del debito comune, che verrebbe collocato senza problemi in grandi quantità e a tassi bassi. Essere valuta di riserva implica del resto creare asset (che per l’Europa sarebbero passività) da mettere a disposizione del resto del mondo. L’aumento dell’indebitamento si accompagnerebbe a una forte rivalutazione dell’euro, che accelererebbe il passaggio da un’economia mercantilista fortemente supportata dalle esportazioni a un’economia di consumatori e di forte spesa pubblica. Il conto da pagare per questi vantaggi arriverebbe sotto forma di deindustrializzazione, solo parzialmente arginata dagli investimenti pubblici o dai sussidi alle imprese.
Come si vede, l’Europa diverrebbe in tempi non troppo lunghi quello che è oggi l’America e ne erediterebbe alla fine i problemi. Sarebbe quindi molto meglio fermarsi a metà strada, ovvero disfarsi del surplus delle partite correnti, usare (possibilmente bene) lo spazio fiscale disponibile, riportare il cambio dell’euro a un livello di equilibrio e non andare oltre. Farsi allettare dal ruolo di valuta di riserva e dalla pioggia di capitali dall’estero che questa comporterebbe sarebbe una forma di hybris.
La Cina, che pure pensa in grande, non ha mai accarezzato l’idea di sostituirsi all’America come fornitore su larga scala di asset di riserva. Lavora molto sulla creazione di una rete di condutture alternativa per i movimenti di capitale, si prepara all’ipotesi di un decoupling finanziario con l’America, irrobustisce il renminbi con iniezioni di oro nei forzieri della banca centrale, crea asset di riserva solo su piccola scala (come le linee swap di renminbi concesse all’Argentina), Sa che il suo enorme surplus delle partite correnti dovrà ridursi, ma non ha fretta di rivalutare il renminbi (che in questa fase deve addirittura difendere) e si indebita sull’interno, non sull’estero.
La dedollarizzazione, dunque, appare più come un fenomeno lento e naturale che come il risultato di eventi traumatici o di una espressa volontà politica. I dollari tenuti a riserva dalle banche centrali in giro per il mondo non vengono venduti, ma le nuove disponibilità vengono impiegate in oro, renminbi o altre valute (un fenomeno che precede Trump e risale alla metà del decennio scorso). La novità è che i flussi di capitali privati verso l’America, che hanno sostenuto il dollaro, i Treasuries e Wall Street in questi anni, si stanno arrestando.
Rimane poi da vedere, più in generale, fino a che punto sia fondato il passaggio repentino del mondo dall’idea dell’eccezionalismo americano a quella del declino accelerato. Salti psicologici di questo tipo avvengono in genere quando i mercati sono sbilanciati, ovvero quando sono troppo lunghi o troppo corti. Non c’è dubbio, oggi il mondo si ritrova molto lungo di America proprio mentre arrivano elementi di segno contrario (dazi, volontà di indebolire il dollaro, dubbi sull’intelligenza artificiale). È in momenti come questi che una narrazione entusiasta diventa disfattista.
Attenzione però a non passare da un eccesso all’altro. La Roma di Romolo Augustolo era già finita da quarant’anni. L’America di oggi è all’offensiva su molti fronti, non intende rinunciare al ruolo del dollaro come valuta di riserva (mantenuto del resto in passato anche nelle fasi di debolezza), aumenta le spese militari e sta imponendo, non subendo, un rassetto generale delle relazioni internazionali.
L’amministrazione Trump ha anche deciso di caricare sul 2025 tutti i costi della ristrutturazione che ha in mente e di riservare al 2026 le scelte che dovrebbero dare sollievo.
Chi ha asset americani, o ne sta considerando l’acquisto, deve dunque decidere su che tempistica si vuole posizionare. Nelle prossime settimane vedremo filiere produttive in crisi, caos nei prezzi (che molti proveranno ad alzare anche se non colpiti dai dazi) e grande volatilità a Wall Street (che non ha ancora scontato del tutto gli elementi negativi). Trump, quando vedrà eccessi di ribasso, metterà sul piatto accordi bilaterali o aperture sui dazi, ma per qualche tempo non riuscirà a invertire stabilmente la direzione dei mercati. La Fed rimarrà immobile, certamente fino a giugno e forse anche oltre.
Verso fine anno vedremo calmarsi la bufera dei dazi e rientrare l’inflazione, soprattutto se l’economia, come è probabile, starà rallentando. Cominceremo anche a vedere tagli di tasse e deregulation.
Nel medio periodo, la scelta di stare strategicamente in America dipenderà da quanto si considerano dovute (e quindi irreversibili) le scelte di Trump. Una futura amministrazione democratica eliminerà i dazi? Perseguirà una politica di dollaro forte? E da che livello? Si riavvicinerà alla Cina?
L’impressione è che, al di là dello stile, molte delle decisioni di Trump siano dovute o bipartisan, come nel caso della Cina. Nel dubbio, i momenti di forza del mercato (più nel 2026 che quest’anno) saranno l’occasione per ridimensionare la presenza dell’America nei portafogli. Senza per questo scomodare prematuramente i barbari alle porte o la caduta dell’impero.